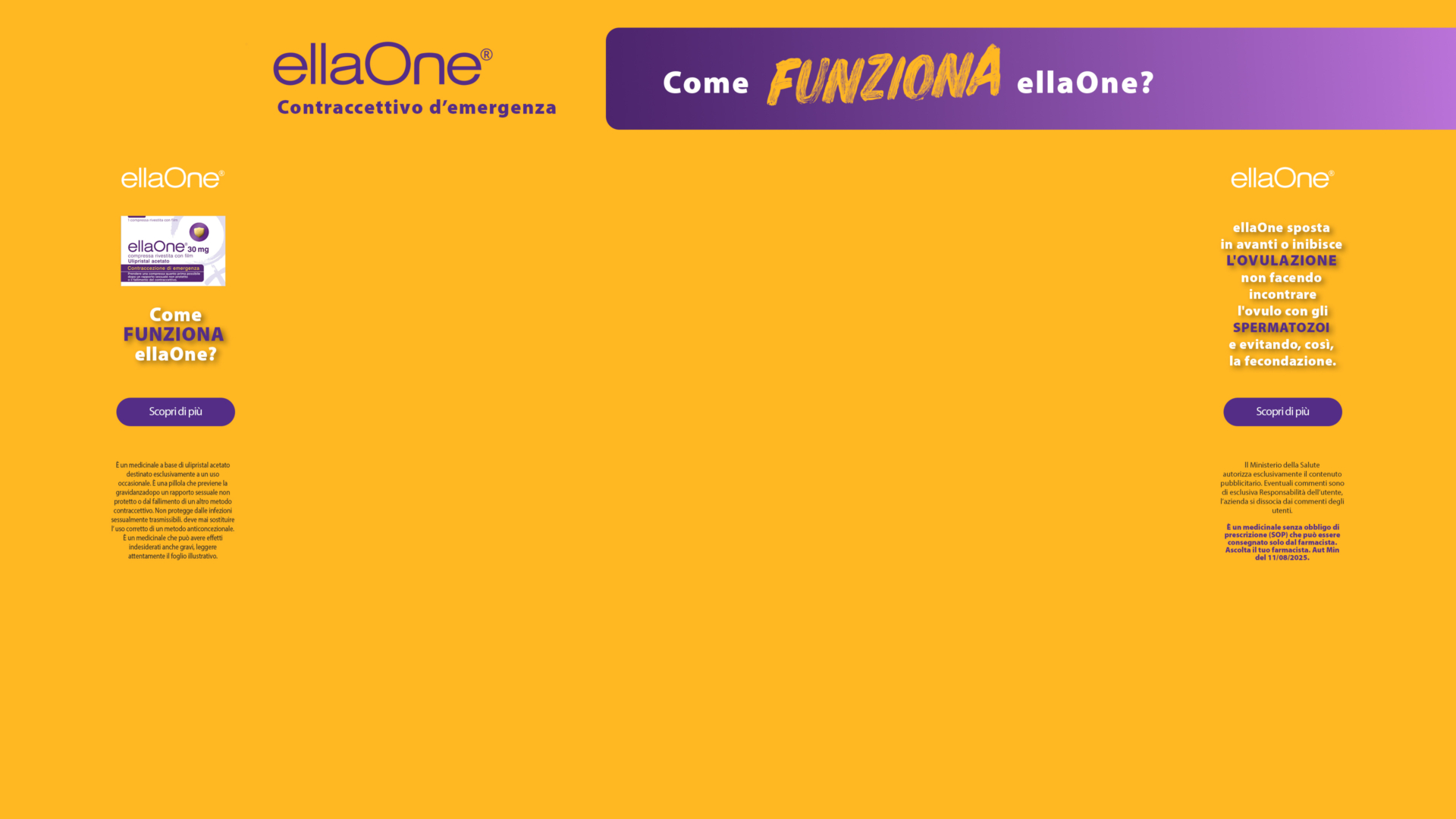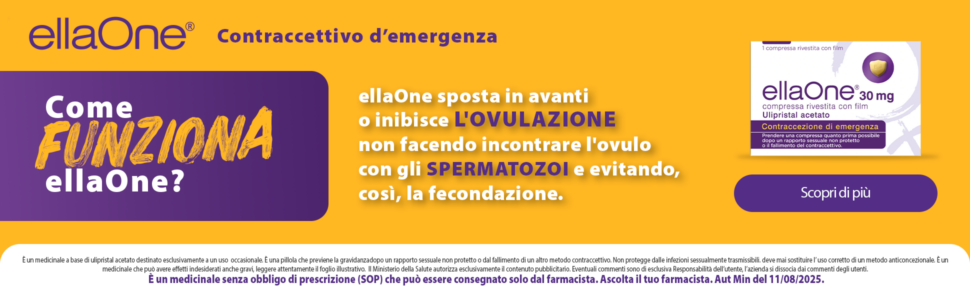- Introduzione Introduzione
- Cos’è il sexting? Cos’è il sexting?
- La doppia morale sessuale La doppia morale sessuale
- Sexting: impatto sul benessere e sull’autostima Sexting: impatto sul benessere e sull’autostima
- Come si può creare una cultura del consenso? Come si può creare una cultura del consenso?
- Cosa fare per favorire una sessualità online libera Cosa fare per favorire una sessualità online libera
Quando un uomo invia un selfie audace viene spesso etichettato come “spavaldo”, ma se lo stesso scatto parte dal telefono di una donna diventa improvvisamente “inappropriato”: lo conferma il rapporto Censis-Bayer (2019), dove il 58% degli italiani condanna il sexting femminile contro appena il 27% che biasima quello maschile.
Questa disparità, radicata negli stereotipi di genere e nello slut-shaming, trova eco anche all’estero: gli studi mostrano come le adolescenti vengono colpevolizzate e le loro immagini circolino per scherno, mentre i coetanei ottengono status sociale.
In un contesto digitale che moltiplica opportunità e rischi, capire perché la stessa azione provochi giudizi opposti è il primo passo per costruire un’intimità online fondata sul consenso e su regole uguali per tutti.
Cos’è il sexting?
Col termine sexting si fa riferimento all’invio, alla ricezione e all’eventuale condivisione di messaggi, fotografie o video di natura erotica tramite smartphone, social o app di messaggistica.
Il primo aspetto da considerare è che il fenomeno non riguarda solo gli adolescenti: la prima grande indagine statunitense sul tema mostrava già nel 2008 che 1 ragazzo su 5 (20%) inviava immagini nude o semi-nude di sé, percentuale che sale a un terzo nei ventenni (31%).
In Italia, la pratica è tutt’altro che marginale: il 25,9% degli adolescenti tra 12 e 18 anni ha ricevuto contenuti a sfondo sessuale e il 12,3% li ha inviati.
Ma anche a livello europeo, i dati evidenziano che il 15% degli 11-16enni ha ricevuto messaggi sessuali online e il 3% li ha mandati.
Nella pratica clinica, il sexting può assumere valenze positive: molte coppie lo utilizzano come gioco erotico per alimentare il desiderio a distanza, ravvivare la quotidianità o sperimentare fantasie difficili da verbalizzare di persona.
Se basato sul consenso reciproco, il comportamento può rafforzare l’autostima corporea e la complicità di coppia.
Dott.ssa Sara SusaniGli stessi scambi diventano però rischiosi quando nascono da pressioni, coinvolgono minorenni o vengono divulgati senza permesso.
In Italia, la diffusione non consensuale di materiali intimi può configurare il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) o, dal 2019, il cosiddetto revenge porn (art. 612-ter c.p.), con pene che arrivano a sei anni di reclusione e pesanti sanzioni pecuniarie.
Il riferimento normativo prepara così il terreno alla riflessione sulla doppia morale.
Sul piano giuridico, infatti, la responsabilità è identica per chiunque violi la privacy altrui, ma nella percezione pubblica non esiste la stessa neutralità.
In altre parole, pur avendo davanti una legge che punisce senza distinguere tra generi, l’opinione sociale continua a vedere il sexting attraverso degli stereotipi: l’uomo che condivide o riceve materiale erotico viene spesso visto come “virile” o addirittura ammirato; la donna, invece, viene etichettata come “imprudente” o “immatura” e rischia un danno reputazionale molto più pesante.
Tutto questo non fa che esaltare il paradosso: l’uguaglianza formale della legge convive con un doppio standard informale che giudica la stessa condotta in modo opposto a seconda del genere di chi la compie.
La doppia morale sessuale
Culturalmente, all’uomo è spesso affidato il ruolo di chi prende l’iniziativa, alla donna quello di chi deve mostrarsi ‘ragionevole’ e contenuta.
Su Internet, questo schema resta sorprendentemente vivo: a parità di messaggi erotici inviati, i maschi sono considerati più coraggiosi e socialmente attraenti, mentre le femmine vengono viste come meno rispettabili e più promiscue, confermando la persistenza di un “sextual double standard”.
Le conseguenze concrete del sextual double standard si colgono nelle cronache giudiziarie quali la vicenda di Tiziana Cantone, sottoposta a un’ondata di slut-shaming culminata nel suicidio nonostante l’assenza di reati da lei commessi, resta un simbolo di condanna pubblica femminile.
Oppure nel caso del 2024 la AS Roma ha licenziato una dipendente dopo la diffusione non consensuale di un suo video, senza sanzionare il calciatore che lo aveva trafugato, segno di tolleranza implicita verso la violazione maschile e di stigmatizzazione verso la vittima donna.
Questi esempi mostrano come la norma sociale punisca soprattutto chi devia dal copione assegnato: l’uomo che ostenta sessualità rafforza la sua identità virile, la donna che fa lo stesso infrange il mandato di modestia e viene rimessa all’ordine attraverso lo slut-shaming.
In questo scenario, diventa cruciale esplicitare tale disparità: solo riconoscendola è possibile sostenere percorsi di empowerment che aiutino le persone a negoziare l’intimità online senza interiorizzare colpa o vergogna indotte da standard doppi.
Sexting: impatto sul benessere e sull’autostima
Quando parliamo di sexting non voluto, cioè di quelle foto o video che spediamo solo perché ci sentiamo spinti a farlo, il peso psicologico è tutt’altro che leggero.
In un gruppo di universitari statunitensi, più della metà ha confessato di aver inviato immagini intime senza essere davvero convint*; chi lo ha fatto racconta di sentirsi meno a posto con se stesso e più vulnerabile alle pressioni del partner.
Nel tempo l’effetto si amplifica: lo stesso team di ricerca ha seguito i partecipanti e ha visto crescere ansia e tristezza, con un impatto più forte nelle ragazze, bersaglio più frequente di commenti offensivi e slut-shaming.
Altri studi parlano chiaro: su 444 giovani adulti il 36% riceve sext indesiderati, il 23% li invia per costrizione e in entrambi i casi aumentano stress e insicurezza, soprattutto nelle ragazze che temono giudizi sul proprio corpo.
Gli stessi numeri mostrano però la faccia opposta della medaglia: quando lo scambio è davvero consensuale, molti ragazzi riferiscono più fiducia in sé e nella propria capacità di attrarre l’altro, segno che il problema non è la foto in sé, ma il contesto in cui viene condivisa.
Per di più, quasi un quarto delle immagini hot circola senza permesso, e chi ne paga il prezzo maggiore, in termini di insulti online e reputazione, sono ancora una volta le ragazze.
Capire questa disparità è il primo passo per proteggere la propria autostima e gestire il sexting in modo sano.
Come si può creare una cultura del consenso?

Nell’educazione al sexting la prima regola è che nulla parte senza un «ti và?».
Le linee guida Insafe ricordano che chiedere esplicitamente il permesso prima di inviare o ricevere contenuti hot e rifarlo ogni volta che cambiano le fantasie o l’umore, riduce già di molto i casi di condivisione non consensuale.
Il consenso online funziona esattamente come dal vivo: deve essere entusiasta, informato e revocabile in qualsiasi momento, perciò abituati ai check-in («tutto ok se continuo?», «preferisci solo audio?») che sono alla base del rispetto digitale.
Sul piano pratico si possono mettere in atto tre mosse rapide:
- usare app con crittografia end-to-end (per esempio Signal o la modalità “chat segreta” di Telegram)
- disattivare i backup automatici su cloud
- cancellare periodicamente la cronologia per ridurre il rischio di furti o condivisioni involontarie.
Gli esperti di sicurezza invitano anche a disattivare il caricamento su iCloud/Google Foto e proteggere il telefono con un codice complesso prima di scattare qualsiasi nudo, poiché senza crittografia un messaggio può essere intercettato lungo il percorso e letto da altre persone.
Per la privacy visiva vale la regola “niente volto, niente indizi”: tagliare la faccia, coprire tatuaggi e scegliere sfondi neutri può evitare che un eventuale inoltro ti renda riconoscibile a scuola o sul lavoro.
Chi cerca un livello extra può sperimentare il «contratto digitale d’intimità»: un breve accordo, verbale o tramite app come We-Consent, in cui i partner specificano cosa si può inviare, conservare o cancellare, sapendo che non è un documento legale ma serve a chiarire confini e aspettative.

Senza filtri
L’importanza del consenso sessuale
Cosa fare per favorire una sessualità online libera
Il quadro che emerge è chiaro: definendo il sexting come uno scambio di contenuti intimi consapevole e reversibile abbiamo visto come la doppia morale sessuale continui a marchiare soprattutto le ragazze, amplificando ansia e vergogna.
Al contrario, l’approvazione sociale rafforza l’autostima maschile. Gli studi longitudinali sul sexting non voluto rivelano un legame diretto con depressione e bassa autostima, a riprova del peso del giudizio esterno.
Per spezzare questo circolo serve mettere al centro il consenso: chiedere prima, rispettare i confini, poter dire “basta” in ogni momento.
Condividi questo articolo con colleghi, genitori e studenti per incoraggiarli a consultare direttamente le fonti scientifiche citate: solo diffondendo dati solidi possiamo costruire una cultura digitale libera da stigma e discriminazioni.
Sara Susani
Psicologa

Sara Susani è psicologa e psicoterapeuta in formazione. Si occupa di benessere psicologico e comunicazione, unendo pratica clinica e scrittura per rendere accessibili temi complessi legati alla crescita personale.