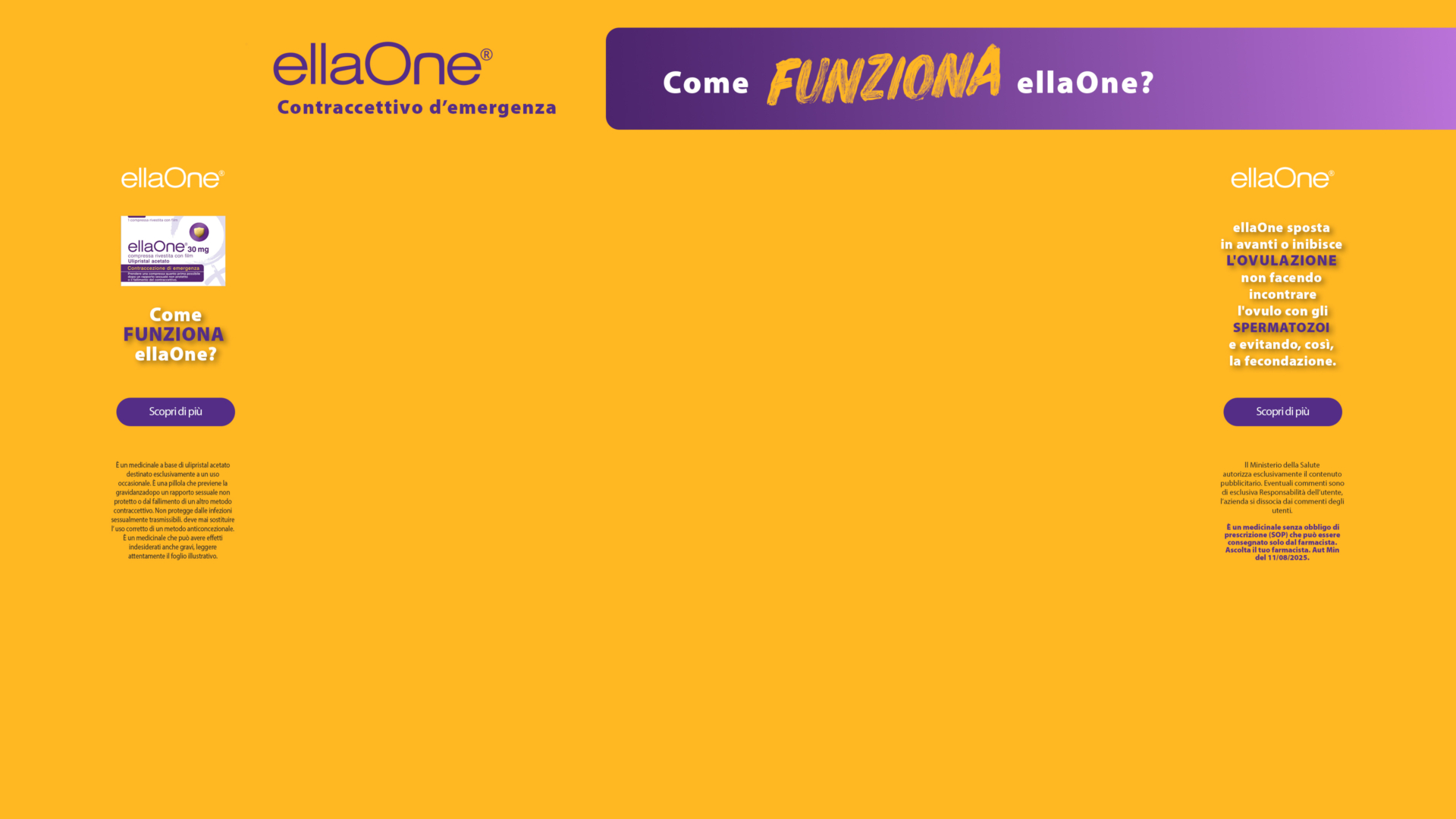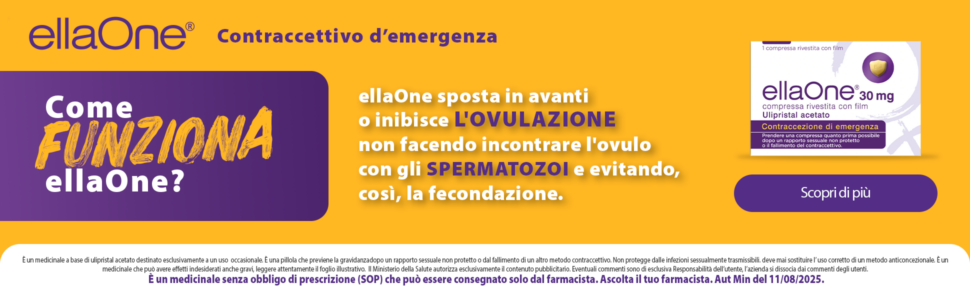- Introduzione Introduzione
- Cosa significa disforia legata al ciclo? Cosa significa disforia legata al ciclo?
- Effetti fisici e psicologici della disforia legata al ciclo Effetti fisici e psicologici della disforia legata al ciclo
- Strategie per affrontare le mestruazioni Strategie per affrontare le mestruazioni
- Perché il ciclo richiede ambienti inclusivi Perché il ciclo richiede ambienti inclusivi
Per molte persone transgender e non binarie, il ciclo mestruale rappresenta una delle esperienze più delicate e invisibilizzate del proprio vissuto corporeo.
In una società in cui le mestruazioni sono ancora narrate attraverso una lente rigidamente binaria, spesso femminilizzata, chi non si riconosce in questa rappresentazione si ritrova esclus*, non solo dalle campagne educative e dai prodotti di uso quotidiano, ma anche dall’ascolto medico, psicologico e sociale.
Parlare di mestruazioni gender free non è una provocazione, ma un atto di cura e di riconoscimento, perché il corpo può diventare un luogo di disforia, di disagio profondo, soprattutto quando manifesta segnali che entrano in conflitto con l’identità di genere percepita.
Il sangue, i crampi, il gonfiore, il mal di testa o la stanchezza non sono solo sintomi fisici: possono trasformarsi in veri e propri trigger emotivi e mentali, amplificando ansia, isolamento e sofferenza psicologica.
In questo articolo, vogliamo dare voce a chi non sempre viene ascoltat*. Esploreremo cosa significa vivere il ciclo in presenza di disforia di genere, quali sono gli effetti fisici e psicologici più comuni e quali strategie possono aiutare a gestire meglio questa esperienza.
Ma soprattutto parleremo di quanto sia urgente ripensare gli ambienti di cura, il linguaggio e i prodotti legati alla salute mestruale in chiave inclusiva, per garantire dignità, rispetto e benessere a tutt*.
Cosa significa disforia legata al ciclo?
Per molte persone transgender e non binarie, il ciclo mestruale non è solo una questione fisica, ma diventa un’esperienza profondamente disforica, che causa disagio.
Durante quei giorni, il corpo sembra parlare con forza, ricordando in modo crudo un’identità sessuata che non rispecchia quella percepita interiormente.
La comparsa del sangue, il gonfiore addominale, i crampi, ma anche semplici gesti quotidiani come acquistare assorbenti o chiedere un antidolorifico, possono riattivare in modo doloroso il conflitto tra ciò che si prova di essere e ciò che il corpo comunica.
Questo tipo di disforia si manifesta su più livelli.
C’è un aspetto fisico, evidente, legato al fatto che il corpo “fa cose” indesiderate.
Ma c’è anche un aspetto più invisibile, psicologico, che riguarda la percezione di sé.
Alcune persone riferiscono di sentirsi estranee al proprio corpo, come se non appartenesse più loro.
In psicologia si parla di alienazione corporea, una condizione in cui il corpo viene vissuto come un elemento esterno, che si guarda con distanza o addirittura con repulsione
(Van de Grift et al., 2016).
Il ciclo può accentuare tutto questo.
Sentirsi “obbligat*” a usare prodotti igienici pensati per un genere che non si riconosce, dover nascondere o spiegare un dolore mestruale che si teme possa mettere in discussione la propria identità, sono esperienze che generano un forte disagio.
In uno studio condotto da Öykü et al. (2025), diversi giovani transgender hanno descritto il ciclo come un momento di “rottura con la propria identità”, capace di influenzare l’umore, l’autostima e il desiderio di socializzare.
Alcuni hanno dichiarato di provare vergogna o addirittura disgusto verso il proprio corpo durante quei giorni, con conseguenze anche sul piano delle relazioni.
Inoltre, è importante ricordare che la disforia mestruale non colpisce tutte le persone allo stesso modo, ma spesso si intreccia con il contesto sociale e culturale.
Quando l’ambiente non è accogliente, quando non si trovano prodotti gender neutral o si viene guardat* con sospetto in farmacia, il senso di esclusione cresce. E con esso, anche la difficoltà a parlare apertamente del proprio vissuto.
Effetti fisici e psicologici della disforia legata al ciclo
Il dolore fisico è solo la superficie. Crampi, nausea, mal di testa, senso di spossatezza: per chi vive disforia di genere, il ciclo mestruale non si limita a un disagio corporeo, ma diventa un’esperienza totalizzante, capace di influenzare anche la mente.
Nei giorni del ciclo, lo specchio può trasformarsi in un nemico, il corpo sembra più estraneo, più invadente.
Gestire il dolore fisico, quando è accompagnato da un senso di non appartenenza a quel corpo, può risultare ancora più complesso e affaticante.
A livello psicologico, il ciclo può diventare un potente attivatore di disforia.
Ogni sintomo, ogni cambiamento del corpo viene letto attraverso una lente distorta: non solo “sto male”, ma “sto male nel corpo sbagliato”.
Questo ha un impatto importante sulla salute mentale. In uno studio è emerso che le persone transgender che hanno mestruazioni riportano livelli significativamente più alti di ansia e depressione durante il periodo mestruale rispetto ai coetanei cisgender, con una correlazione diretta tra dolore fisico e disagio psicologico (Öykü et al., 2025).
Il tono dell’umore si abbassa, l’irritabilità aumenta, e si fa strada una sensazione di isolamento, spesso aggravata dal fatto che se ne parla poco, o per niente.
Il silenzio, infatti, è un altro grande protagonista. Molte persone evitano di condividere la propria esperienza per paura di non essere credute, o peggio, di doverla spiegare e giustificare.
Questo accade anche in contesti sanitari: ginecologi, medici di base e operatori della salute spesso non sono formati per comprendere come il ciclo possa influenzare l’identità di genere, lasciando le persone senza uno spazio sicuro in cui essere ascoltate. E quando la sofferenza viene ignorata, si amplifica.
C’è anche un altro aspetto che contribuisce a questo senso di esclusione: la maggior parte dei contenuti, prodotti e campagne educative sul ciclo sono ancora pensati per donne cisgender.
Assorbenti con packaging rosa, linguaggio esclusivamente femminile, ambienti in cui si dà per scontato che mestruare significhi essere donna: tutto questo comunica implicitamente che chi non si riconosce in quella narrazione non ha diritto di esistere in quel discorso.
E invece ce l’ha. La salute mestruale deve poter essere affrontata anche in chiave gender free, inclusiva e rispettosa.
Strategie per affrontare le mestruazioni in ottica gender free

Quando il ciclo diventa un momento di forte disforia, trovare strategie che aiutino a sentirsi più al sicuro, più in controllo, può fare una grande differenza.
Alcune soluzioni pratiche partono da oggetti semplici, come le mutande assorbenti gender neutral, che permettono di gestire il flusso senza il disagio legato all’uso di prodotti con packaging iper femminizzati.
Sono prodotti pensati in modo più inclusivo, discreti, e spesso più comodi per chi vive male il contatto diretto con il sangue.
Per chi si sente a disagio con assorbenti esterni, esistono dispositivi interni come il disco o la coppetta mestruale, che riducono la percezione visiva del ciclo.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che non esiste una “soluzione giusta per tutt*”: il punto è offrire alternative, in modo che ogni persona possa scegliere ciò che la fa sentire meglio nel proprio corpo.
Anche piccoli accorgimenti come l’uso di borse dell’acqua calda, il riposo e un’alimentazione più leggera nei giorni di ciclo, possono aiutare ad alleviare il dolore fisico, e di conseguenza anche quello psicologico.
Sul piano emotivo, uno strumento efficace è il journaling. Scrivere i propri pensieri, senza filtro, aiuta a dare forma a ciò che si prova e a creare uno spazio interno di riconoscimento.
Questo è particolarmente utile per chi si sente incompres* o non legittimat* a raccontare il proprio vissuto.
Anche ricevere supporto da persone care o da comunità informate può aiutare. Avere almeno un luogo, fisico o virtuale, dove sentirsi accolt* senza dover spiegare tutto da capo, fa la differenza.
La validazione emotiva, ovvero il semplice sentirsi dire “quello che provi ha senso”, è uno strumento terapeutico potentissimo.
Spesso, viene sottovalutato, ma chi vive una disforia legata al ciclo sa bene quanto possa alleggerire il carico interiore.
Infine, c’è un aspetto che merita attenzione: l'auto compassione. Non è debolezza, ma cura.
Sentirsi autorizzat* a rallentare, a dire “oggi non ce la faccio”, è un atto di rispetto verso di sé. Non si tratta di arrendersi, ma di riconoscere che quei giorni possono essere più faticosi, e va bene così.
Questo approccio, secondo Neff (2003), aiuta a ridurre la ruminazione e ad aumentare la resilienza emotiva, soprattutto in persone che affrontano quotidianamente micro-aggressioni o stigma.
Perché il ciclo richiede ambienti inclusivi: ascolto e rispetto nelle mestruazioni gender free
Non basta parlare di salute mestruale, serve farlo in modo che tutte le persone si sentano viste, comprese e rispettate.
Per chi vive un’identità di genere non conforme, affrontare il ciclo in ambienti medici, scolastici o anche solo pubblici può diventare motivo di ansia e vergogna.
Medici, psicologi, ginecologi e farmacisti dovrebbero essere consapevoli che le mestruazioni non sono soltanto un fatto biologico, ma anche una possibile fonte di sofferenza psicologica, soprattutto per le persone transgender o non binarie.
La letteratura scientifica sottolinea da anni l’importanza di un approccio informato e inclusivo.
Ad esempio, è stato dimostrato come adolescenti transgender e non conformi al genere riferiscano tassi molto più alti di evitamento delle cure sanitarie, spesso dovuto alla paura di essere fraintesi, etichettati o discriminati.
Questo accade anche quando si tratta di tematiche intime come il ciclo mestruale, ancora fortemente legato a un immaginario esclusivamente femminile e binario (Axenya et al., 2020).
Per rendere davvero accoglienti gli spazi dedicati alla salute, non servono solo grandi rivoluzioni, ma anche piccoli cambiamenti che comunichino rispetto.
Ad esempio: moduli medici che permettano di indicare i pronomi, personale formato sull’uso di un linguaggio inclusivo, cartellonistica gender neutral nei bagni pubblici, oppure confezioni di prodotti mestruali non rosa e non marcati “per donne”.
Questi dettagli non sono superficiali: sono segnali silenziosi che dicono “sei il benvenut* anche qui, così come sei”.
Anche nei contesti psicologici, la sensibilità a questi temi può fare la differenza. L’ascolto empatico, quando è sincero e privo di giudizio, ha un effetto immediato sulla persona che si racconta.
La validazione dell’esperienza, il semplice atto di riconoscere che ciò che una persona vive ha senso, è una forma di cura potentissima (Carlos et al., 2015).
In un mondo ancora dominato da schemi rigidi e linguaggi binari, ogni gesto che rompe questa rigidità è un passo verso una medicina e una psicologia più umane.
L’identità di una persona non si cura, si accompagna. E per farlo, bisogna prima di tutto saper ascoltare.
Sara Susani
Psicologa

Sara Susani è psicologa e psicoterapeuta in formazione. Si occupa di benessere psicologico e comunicazione, unendo pratica clinica e scrittura per rendere accessibili temi complessi legati alla crescita personale.